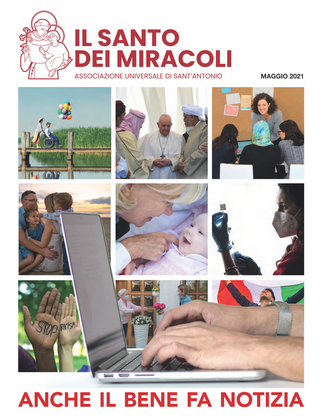Anno 133 - Maggio 2021Scopri di più
Il campo dei ricordi
Germano Bertin

Ho un campo. Un campo che papà mi ha lasciato. Un campo che lui stesso, a sua volta, aveva ricevuto. Oggi: legame, continuità, consegna, collegamento. Un filo rosso. Per me: il campo dei ricordi. Lí tutto torna presente, vivo, vissuto, vivibile. Ricordo le mani, robuste e dinamiche, sicure e abili, solide e pronte di papà quando, a inizio primavera, cominciava la potatura del suo vigneto.
Armeggiava sottili ramoscelli di vimini come fossero duttili funicelle con cui riusciva a dare forma e direzione a quei tralci piangenti che si mostravano già impazienti di crescere. Non mi stancavo. Quei gesti uguali, sempre nuovi a ogni movimento, mi catturavano. Restavo ore, a guardare. Catturato. Il suo silenzio, ricco di uno sguardo che vedeva già come sarebbero andate a finire le cose, diventava il mio. E stavo bene.
Avevo la sensazione di essere in prima fila a gustare l’inizio di una cosa straordinaria, riservata a pochi. Ricordo, tuttavia, anche qualche suo sguardo severo, quando, per esempio, ancora bambino, avevo raccolto prematuramente alcuni grappoli d’uva, ancora acerbi: uno spreco imperdonabile per lui, uomo essenziale e attento ai dettagli. Per me, quello è anche il campo dell’apprendimento.
Lí ho imparato a prendermi cura io stesso della vite: dopo ogni temporale sapevo che dovevo correre a effettuare il necessario trattamento di protezione che avrebbe lenito le ferite che la forza tagliente della grandine estiva lasciava, spesso, sulla scorza sempre troppo fragile di quei grappoli. Su quel campo ho appreso che le cose vanno fatte quando “è tempo”: non quando “si può”. La natura, come la vita e le relazioni che la tessono, chiedono presenza: esserci al momento giusto. Cosí il vivere si fa profezia. Il domani è frutto che nasce lontano. Attraversa l’oggi. Accade subito dopo.
Ma se non ricordi e se non agisci oggi, si rischia di sciupare tutto. Per me, quello è il campo della presenza. E del domani. Ancora oggi, mentre solo, o talora a mia volta sostenuto dallo sguardo curioso e apprendista di mio figlio, lavoro quella terra che mio padre sapeva coltivare con esperienza e leggerezza, vorrei dire con tenerezza che ancora gli invidio, avverto chiara la sua presenza. Talora mi volto, repentino, e lo riconosco. Mi sembra di vederlo, mentre mi guarda: ma lui già non c’è.
Provo dentro, allora, non tristezza, ma, come direbbe meglio la lingua portoghese, “saudade”: nostalgia, dolore intimo, capace di suscitare, allo stesso tempo, consolazione e prospettiva. Il cuore, ma anche i miei occhi, si gonfiano di mare: assaporo dentro una indescrivibile sensazione di pienezza, e insieme di futuro. E mi sorprendo bagnato di sale.
Felicità accompagnata, vestito nuovo, tessuto di ieri. Lo sguardo punta oltre, piú avanti. E ricomincio a potare, a vangare, a coccolare quella terra che mi insegna fedeltà, mistero, tenerezza, forza, resistenza, fecondità: soprattutto, attesa. Mi piace immergere le mani nella terra, conoscerne la durezza e insieme la fragranza: mi fermo. Osservo. Trattengo. Lascio andare. Mi fermo e accarezzo questa mia terra, sicuro che questo gesto genera domani. Oggi quel campo mi abita dentro. Con delicatezza e consapevolezza sfioro ogni vissuto e ogni incontro. Guardo ogni germoglio.
Accarezzo ogni fiore. E ricevo. Cosí, ogni oggi diventa il mio campo. Quel campo che, come ogni «albero – scrive Erri De Luca – ha bisogno di due cose: terra sotto e bellezza fuori... alleanza tra il vicino e il perfetto lontano».


 English
English Français
Français